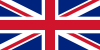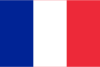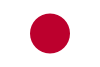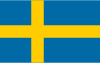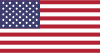La misurazione della temperatura può essere suddivisa in due categorie: a contatto e senza contatto. Nella pratica, i termocoppie e i sensori Pt 100 sono i rappresentanti più comunemente utilizzati del primo gruppo. Essi devono entrare in contatto con l'oggetto da misurare e misurano in linea di principio la propria temperatura, che è simile a quella dell'oggetto. Ciò comporta una risposta relativamente lenta. I sensori senza contatto misurano l'energia infrarossa (IR) irradiata da un oggetto, hanno tempi di risposta rapidi e sono spesso utilizzati per misurare oggetti in movimento, oggetti che si trovano nel vuoto o che sono inaccessibili per altri motivi.
I termometri a infrarossi o pirometri sono sensori altamente sofisticati che hanno trovato ampio impiego nella ricerca e nell'industria. Questo articolo descrive in modo comprensibile la teoria alla base di questo principio di misurazione e come tale teoria possa aiutare a gestire i diversi parametri specifici dell'applicazione che i potenziali utenti devono affrontare.
Nozioni di base sulla misurazione della temperatura a infrarossi
Introduzione

Fig. 1 Spettro elettromagnetico
Teoria e nozioni di base
La radiazione infrarossa fu scoperta nel 1666 da Sir Isaac Newton quando fece passare la luce solare attraverso un prisma e la separò nei colori dell'arcobaleno. Nel 1880, Sir William Herschel compì il passo successivo determinando l'energia relativa dei singoli colori. Scoprì anche l'energia al di là dello spettro visibile. All'inizio del 1900, Planck, Stefan, Boltzmann, Wien e Kirchhoff definirono ulteriormente le attività dello spettro elettromagnetico e stabilirono dati ed equazioni quantitative per descrivere l'energia IR.
I termometri a infrarossi misurano la temperatura misurando la radiazione infrarossa emessa da tutti i materiali e gli oggetti con una temperatura superiore allo zero assoluto (0° Kelvin). Nella versione più semplice, una lente focalizza l'energia IR sul rilevatore, che converte l'energia in un segnale elettrico. Dopo aver compensato la temperatura ambiente, questo segnale può essere visualizzato. Questa configurazione consente di misurare la temperatura da una certa distanza e senza contatto con l'oggetto da misurare. Ciò rende il termometro a infrarossi adatto a compiti di misurazione in cui le termocoppie o altri sensori non possono essere utilizzati o forniscono risultati imprecisi. Alcuni esempi tipici sono la misurazione di oggetti in movimento o molto piccoli, di parti sotto tensione o di sostanze chimiche aggressive, la misurazione in forti campi elettromagnetici, la misurazione di oggetti nel vuoto o in altri ambienti chiusi e le applicazioni in cui è richiesto un tempo di risposta rapido.
I primi progetti di termometri a infrarossi esistono fin dal XIX secolo. Alcuni concetti sono stati introdotti da Charles A. Darling nel suo libro "Pyrometry", pubblicato nel 1911.
Ci è voluto fino al 1930 prima che la tecnologia fosse disponibile per mettere in pratica questi concetti. Da allora, questi strumenti hanno subito un continuo sviluppo, nel corso del quale sono state acquisite ampie conoscenze ed esperienze applicative. Oggi questo concetto si è affermato come metodo di misura standard ed è utilizzato nell'industria e nella ricerca.
I termometri a infrarossi misurano la temperatura misurando la radiazione infrarossa emessa da tutti i materiali e gli oggetti con una temperatura superiore allo zero assoluto (0° Kelvin). Nella versione più semplice, una lente focalizza l'energia IR sul rilevatore, che converte l'energia in un segnale elettrico. Dopo aver compensato la temperatura ambiente, questo segnale può essere visualizzato. Questa configurazione consente di misurare la temperatura da una certa distanza e senza contatto con l'oggetto da misurare. Ciò rende il termometro a infrarossi adatto a compiti di misurazione in cui le termocoppie o altri sensori non possono essere utilizzati o forniscono risultati imprecisi. Alcuni esempi tipici sono la misurazione di oggetti in movimento o molto piccoli, di parti sotto tensione o di sostanze chimiche aggressive, la misurazione in forti campi elettromagnetici, la misurazione di oggetti nel vuoto o in altri ambienti chiusi e le applicazioni in cui è richiesto un tempo di risposta rapido.
I primi progetti di termometri a infrarossi esistono fin dal XIX secolo. Alcuni concetti sono stati introdotti da Charles A. Darling nel suo libro "Pyrometry", pubblicato nel 1911.
Ci è voluto fino al 1930 prima che la tecnologia fosse disponibile per mettere in pratica questi concetti. Da allora, questi strumenti hanno subito un continuo sviluppo, nel corso del quale sono state acquisite ampie conoscenze ed esperienze applicative. Oggi questo concetto si è affermato come metodo di misura standard ed è utilizzato nell'industria e nella ricerca.
Principio di misura
Come già detto, tutti i corpi con una temperatura superiore a 0°K emettono energia infrarossa. La radiazione infrarossa è la parte dello spettro elettromagnetico che si trova tra la luce visibile e le onde radio. La lunghezza d'onda della radiazione IR va da 0,7 µm a 1000 µm, come illustrato nella Figura 1. In pratica, tuttavia, solo le lunghezze d'onda da 0,7 a 20 µm di questa gamma di frequenze sono adatte alla misurazione della temperatura. Attualmente non esistono rivelatori abbastanza sensibili da misurare le piccole quantità di energia emesse al di sopra di una lunghezza d'onda di 20 µm. L'energia aumenta in proporzione alla quarta potenza della temperatura.
La curva (Figura 2) mostra l'energia emessa da un corpo nero in un intervallo di temperatura compreso tra 700 K e 1300 K. Come si può notare, la maggior parte dell'energia è emessa da un corpo nero. Come si può notare, la maggior parte di essa si trova al di là della gamma visibile Le radiazioni IR non sono percepibili dall'occhio umano, ma è comunque utile pensare a queste radiazioni come alla luce visibile per comprendere il principio di funzionamento e i problemi che si presentano nelle applicazioni.
Per molti aspetti, le radiazioni IR si comportano effettivamente come la luce visibile. La radiazione IR viaggia in linea retta lontano dalla sorgente di radiazione e può essere riflessa o assorbita dagli oggetti che si trovano nel percorso del fascio. Per la maggior parte degli oggetti non trasparenti all'occhio umano, la radiazione IR viene in parte riflessa e in parte assorbita dall'oggetto. Una parte dell'energia assorbita viene riflessa internamente e una parte viene emessa nuovamente. Questo vale anche per gli oggetti trasparenti all'occhio umano, come il vetro, i gas e le sottili pellicole di plastica trasparente. Inoltre, una parte della radiazione penetra attraverso l'oggetto. La Figura 3 illustra questi processi. Complessivamente, questi processi contribuiscono a quello che chiamiamo il fattore di emissione di un oggetto o di un materiale.
La curva (Figura 2) mostra l'energia emessa da un corpo nero in un intervallo di temperatura compreso tra 700 K e 1300 K. Come si può notare, la maggior parte dell'energia è emessa da un corpo nero. Come si può notare, la maggior parte di essa si trova al di là della gamma visibile Le radiazioni IR non sono percepibili dall'occhio umano, ma è comunque utile pensare a queste radiazioni come alla luce visibile per comprendere il principio di funzionamento e i problemi che si presentano nelle applicazioni.
Per molti aspetti, le radiazioni IR si comportano effettivamente come la luce visibile. La radiazione IR viaggia in linea retta lontano dalla sorgente di radiazione e può essere riflessa o assorbita dagli oggetti che si trovano nel percorso del fascio. Per la maggior parte degli oggetti non trasparenti all'occhio umano, la radiazione IR viene in parte riflessa e in parte assorbita dall'oggetto. Una parte dell'energia assorbita viene riflessa internamente e una parte viene emessa nuovamente. Questo vale anche per gli oggetti trasparenti all'occhio umano, come il vetro, i gas e le sottili pellicole di plastica trasparente. Inoltre, una parte della radiazione penetra attraverso l'oggetto. La Figura 3 illustra questi processi. Complessivamente, questi processi contribuiscono a quello che chiamiamo il fattore di emissione di un oggetto o di un materiale.

Fig. 2 Proprietà di radiazione dei corpi neri

Fig. 3 Scambio termico e irraggiamento
Come per la luce visibile, più una superficie è levigata, più energia riflette. La finitura della superficie influenza quindi anche il fattore di emissione. Quando si misura la temperatura, questo aspetto è particolarmente importante per gli oggetti che sono impermeabili agli IR e hanno un fattore di emissione basso. Un oggetto in acciaio inossidabile lucidato ha un fattore di emissione significativamente inferiore rispetto allo stesso oggetto con una superficie ruvida. Dopo la lavorazione, ad esempio dopo la tornitura, l'oggetto grezzo presenta molte piccole scanalature e irregolarità che riducono significativamente la riflettività del pezzo.
La legge di conservazione dell'energia afferma che la somma dei coefficienti dell'energia IR trasmessa, riflessa ed emessa (assorbita) deve essere uguale a 1.
σλ + αλ + τλ = 1
Inoltre, il fattore di emissione è uguale al fattore di assorbimento:
ελ = αλ
vale quanto segue:
ελ = 1 - σλ+ τλ
La legge di conservazione dell'energia afferma che la somma dei coefficienti dell'energia IR trasmessa, riflessa ed emessa (assorbita) deve essere uguale a 1.
σλ + αλ + τλ = 1
Inoltre, il fattore di emissione è uguale al fattore di assorbimento:
ελ = αλ
vale quanto segue:
ελ = 1 - σλ+ τλ

Abb. 4 Confronto tra corpo nero, corpo grigio e faretti colorati
Il coefficiente può essere utilizzato nell'equazione di Planck come variabile che descrive le proprietà di una superficie rispetto alla lunghezza d'onda. Per gli oggetti opachi, l'equazione può essere semplificata come segue:
ελ = 1 - σλ
Gli oggetti che non riflettono né trasmettono la radiazione infrarossa sono definiti corpi neri. Non si conosce un corpo nero naturale. Per scopi teorici e per il calcolo di altri oggetti, un corpo nero ha un fattore di emissione pari a 1,0. In pratica, la migliore approssimazione di un vero corpo nero si ottiene utilizzando una sfera impermeabile agli infrarossi con una piccola apertura d'ingresso cilindrica. La superficie interna di un tale oggetto ha un fattore di emissione di 0,998.
Il fattore di emissione è una misura del rapporto tra la radiazione termica emessa da un corpo grigio e da un corpo nero alla stessa temperatura. Un corpo grigio è un oggetto che ha lo stesso fattore di emissione a tutte le lunghezze d'onda ed emette meno radiazione infrarossa di un corpo nero. Un radiatore Bund è un oggetto il cui fattore di emissione cambia con la lunghezza d'onda, come nel caso dei metalli, ad esempio.
ελ = 1 - σλ
Gli oggetti che non riflettono né trasmettono la radiazione infrarossa sono definiti corpi neri. Non si conosce un corpo nero naturale. Per scopi teorici e per il calcolo di altri oggetti, un corpo nero ha un fattore di emissione pari a 1,0. In pratica, la migliore approssimazione di un vero corpo nero si ottiene utilizzando una sfera impermeabile agli infrarossi con una piccola apertura d'ingresso cilindrica. La superficie interna di un tale oggetto ha un fattore di emissione di 0,998.
Il fattore di emissione è una misura del rapporto tra la radiazione termica emessa da un corpo grigio e da un corpo nero alla stessa temperatura. Un corpo grigio è un oggetto che ha lo stesso fattore di emissione a tutte le lunghezze d'onda ed emette meno radiazione infrarossa di un corpo nero. Un radiatore Bund è un oggetto il cui fattore di emissione cambia con la lunghezza d'onda, come nel caso dei metalli, ad esempio.
Materiali diversi hanno anche fattori di emissione diversi e quindi emettono radiazioni IR con un'intensità diversa a una determinata temperatura. Questo non è generalmente una funzione del colore, a meno che il materiale della vernice non sia chiaramente diverso da quello dell'oggetto. Un esempio di questo fenomeno è la vernice ad effetto metallico, che contiene grandi quantità di particelle di alluminio. La maggior parte delle vernici ha lo stesso fattore di emissione, indipendentemente dalla tonalità del colore. L'alluminio, invece, ha un fattore di emissione molto diverso, che si traduce in un fattore di emissione diverso per la vernice a effetto metallico.
Oltre alla composizione e alla struttura superficiale di un oggetto, un terzo fattore ha un effetto indiretto sul fattore di emissione: la gamma spettrale del sensore. Non ha un'influenza diretta sull'oggetto, ma sul modo in cui il sensore percepisce lo spettro emesso dall'oggetto.
I materiali parzialmente trasparenti, come il vetro, la plastica o il silicone, possono essere misurati in un intervallo in combinazione con i filtri selettivi corrispondenti.
Oltre alla composizione e alla struttura superficiale di un oggetto, un terzo fattore ha un effetto indiretto sul fattore di emissione: la gamma spettrale del sensore. Non ha un'influenza diretta sull'oggetto, ma sul modo in cui il sensore percepisce lo spettro emesso dall'oggetto.
I materiali parzialmente trasparenti, come il vetro, la plastica o il silicone, possono essere misurati in un intervallo in combinazione con i filtri selettivi corrispondenti.

Fig. 5 Fattore di emissione di diversi materiali in funzione della lunghezza d'onda
Dai paragrafi precedenti è emerso chiaramente che il fattore di emissione è un parametro particolarmente importante nella misurazione della temperatura a infrarossi. Finché il fattore di emissione dell'oggetto misurato non è noto con precisione e non viene preso in considerazione nella misurazione, è molto improbabile che i valori ottenuti siano accurati. Esistono essenzialmente due modi per determinare il fattore di emissione. Il fattore di emissione può essere ricavato da tabelle o determinato da una misurazione comparativa. Tuttavia, poiché i dati delle tabelle sono generalmente determinati in condizioni di laboratorio idealizzate, non si tiene conto delle influenze ambientali, che causano un'enorme deviazione, soprattutto a fattori bassi. Inoltre, le tabelle non specificano la temperatura e la lunghezza d'onda di misurazione. In prima approssimazione, il valore della tabella è certamente molto utile. Per la misurazione comparativa, l'oggetto di misura viene misurato con una termocoppia o un altro sensore di temperatura per impostare successivamente il fattore di emissione sul termometro IR in modo che visualizzi la stessa temperatura. Come regola generale, la maggior parte dei materiali opachi e non metallici ha un fattore di emissione alto e relativamente stabile, compreso tra 0,85 e 0,95. Per la maggior parte dei materiali metallici non ossidati, il fattore di emissione è compreso tra 0,2 e 0,5, ad eccezione di oro, argento e alluminio, che hanno un fattore di emissione ancora più basso. La temperatura di questi metalli è quindi difficile da misurare con i termometri a infrarossi, poiché la componente di riflessione della radiazione ambientale è dello stesso ordine di grandezza o superiore alla radiazione dell'oggetto.
Mentre è quasi sempre possibile determinare il fattore di emissione del materiale, i problemi sorgono quando il materiale non ha un fattore di emissione costante, ma cambia con la temperatura. Questo vale per la maggior parte dei metalli, ma anche per alcuni altri materiali, come il silicio o le ceramiche monocristalline ad alta purezza. In questo caso, la misurazione comparativa e la regolazione devono essere effettuate alla temperatura critica del processo.
Le equazioni e le formule su cui si basa la misurazione della temperatura sono note e collaudate da tempo. È improbabile che l'utente debba utilizzare le formule nel suo lavoro quotidiano con i termometri IR. Tuttavia, la conoscenza di questi principi consente di comprendere meglio come determinate variabili e parametri si influenzino a vicenda. Le formule più importanti riassunte sono:
1. Legge di Kirchhoff sulla radiazione
A una data temperatura T e a una data lunghezza d'onda l, l'emissività e è uguale all'assorbibilità
e = α
Da ciò consegue che il flusso radiante øλ di un oggetto reale è uguale a quello del corpo nero øs alla stessa temperatura moltiplicato per l'emissività dell'oggetto
øλ = ε * øs
2. Legge di Stefan-Boltzmann Legge di Stefan-Boltzmann
Maggiore è la temperatura T di un oggetto, maggiore è la potenza radiante P emessa per una data emissività ε e superficie radiante A (k = costante)
P = k*ε*A*T4
3. Legge di Wien dello spostamento Legge di Wien sullo spostamento
La lunghezza d'onda in cui si trova il massimo della radiazione energetica si sposta verso l'intervallo delle onde corte con l'aumentare della temperatura.
λmax = 2,89 * 103 μmK/T
4. Equazione di Planck Equazione di Planck
Questa equazione descrive la relazione tra lunghezza d'onda, temperatura T e potenza radiante
Mentre è quasi sempre possibile determinare il fattore di emissione del materiale, i problemi sorgono quando il materiale non ha un fattore di emissione costante, ma cambia con la temperatura. Questo vale per la maggior parte dei metalli, ma anche per alcuni altri materiali, come il silicio o le ceramiche monocristalline ad alta purezza. In questo caso, la misurazione comparativa e la regolazione devono essere effettuate alla temperatura critica del processo.
Le equazioni e le formule su cui si basa la misurazione della temperatura sono note e collaudate da tempo. È improbabile che l'utente debba utilizzare le formule nel suo lavoro quotidiano con i termometri IR. Tuttavia, la conoscenza di questi principi consente di comprendere meglio come determinate variabili e parametri si influenzino a vicenda. Le formule più importanti riassunte sono:
1. Legge di Kirchhoff sulla radiazione
A una data temperatura T e a una data lunghezza d'onda l, l'emissività e è uguale all'assorbibilità
e = α
Da ciò consegue che il flusso radiante øλ di un oggetto reale è uguale a quello del corpo nero øs alla stessa temperatura moltiplicato per l'emissività dell'oggetto
øλ = ε * øs
2. Legge di Stefan-Boltzmann Legge di Stefan-Boltzmann
Maggiore è la temperatura T di un oggetto, maggiore è la potenza radiante P emessa per una data emissività ε e superficie radiante A (k = costante)
P = k*ε*A*T4
3. Legge di Wien dello spostamento Legge di Wien sullo spostamento
La lunghezza d'onda in cui si trova il massimo della radiazione energetica si sposta verso l'intervallo delle onde corte con l'aumentare della temperatura.
λmax = 2,89 * 103 μmK/T
4. Equazione di Planck Equazione di Planck
Questa equazione descrive la relazione tra lunghezza d'onda, temperatura T e potenza radiante

Concezione dei termometri a infrarossi
Un termometro a infrarossi è costituito fondamentalmente dai seguenti blocchi funzionali:
1. Una lente che focalizza l'energia emessa dall'oggetto.
2. Un rilevatore che converte l'energia radiante in un segnale elettrico.
3. Una regolazione del fattore di emissione per adattare il termometro alle proprietà dell'oggetto da misurare.
4Una compensazione della temperatura ambiente che impedisce alla temperatura del termometro di essere inclusa nel segnale di uscita.
Per molti anni, la maggior parte dei termometri IR disponibili in commercio ha seguito questo concetto. Le loro applicazioni erano limitate e, a posteriori, non fornivano risultati di misura soddisfacenti. Per gli standard dell'epoca, tuttavia, erano perfettamente adeguati e molto robusti.
1. Una lente che focalizza l'energia emessa dall'oggetto.
2. Un rilevatore che converte l'energia radiante in un segnale elettrico.
3. Una regolazione del fattore di emissione per adattare il termometro alle proprietà dell'oggetto da misurare.
4Una compensazione della temperatura ambiente che impedisce alla temperatura del termometro di essere inclusa nel segnale di uscita.
Per molti anni, la maggior parte dei termometri IR disponibili in commercio ha seguito questo concetto. Le loro applicazioni erano limitate e, a posteriori, non fornivano risultati di misura soddisfacenti. Per gli standard dell'epoca, tuttavia, erano perfettamente adeguati e molto robusti.

Abb. 6 Schema a blocchi di un termometro IR
I moderni termometri a infrarossi si basano su questo concetto di base, ma sono stati notevolmente perfezionati nel tempo. Le differenze più importanti sono l'uso di una varietà di tipi diversi di rivelatori, il filtraggio selettivo del segnale IR, la linearizzazione e l'amplificazione del segnale del rivelatore e i segnali di uscita della temperatura standardizzati, come 4-20 mA o 0-10 V CC. La Figura 6 mostra uno schema a blocchi di un moderno pirometro a infrarossi.
Probabilmente il progresso più significativo nella misurazione della temperatura IR è stato raggiunto con l'introduzione di filtri selettivi per la radiazione IR. Ciò ha reso possibile l'utilizzo di rivelatori più sensibili e di amplificatori di segnale più stabili. Mentre i primi termometri IR dipendevano da un ampio spettro IR per ottenere un segnale di uscita utilizzabile dal rivelatore, una larghezza di banda di 1 μm o più è del tutto sufficiente per i rivelatori moderni. La necessità di restringere lo spettro e di selezionare determinate lunghezze d'onda deriva dal fatto che spesso le misure devono essere effettuate attraverso un mezzo la cui temperatura non deve essere inclusa nella misura a causa del contenuto di carbonio o idrogeno. Inoltre, a volte è necessario misurare la temperatura di oggetti o gas che sono permeabili in un ampio intervallo dello spettro IR. Alcuni esempi di limitazione selettiva dello spettro sono:
- 8 - 14 μm: le influenze dell'umidità dell'aria sono escluse anche su distanze maggiori.
- 7,9 μm: consente di misurare pellicole di plastica sottili che sono permeabili all'IR su ampi intervalli.
- 3,86 μm: l'interferenza con CO2 e vapore acqueo nelle fiamme e nei gas di scarico della combustione è efficacemente soppressa.
Probabilmente il progresso più significativo nella misurazione della temperatura IR è stato raggiunto con l'introduzione di filtri selettivi per la radiazione IR. Ciò ha reso possibile l'utilizzo di rivelatori più sensibili e di amplificatori di segnale più stabili. Mentre i primi termometri IR dipendevano da un ampio spettro IR per ottenere un segnale di uscita utilizzabile dal rivelatore, una larghezza di banda di 1 μm o più è del tutto sufficiente per i rivelatori moderni. La necessità di restringere lo spettro e di selezionare determinate lunghezze d'onda deriva dal fatto che spesso le misure devono essere effettuate attraverso un mezzo la cui temperatura non deve essere inclusa nella misura a causa del contenuto di carbonio o idrogeno. Inoltre, a volte è necessario misurare la temperatura di oggetti o gas che sono permeabili in un ampio intervallo dello spettro IR. Alcuni esempi di limitazione selettiva dello spettro sono:
- 8 - 14 μm: le influenze dell'umidità dell'aria sono escluse anche su distanze maggiori.
- 7,9 μm: consente di misurare pellicole di plastica sottili che sono permeabili all'IR su ampi intervalli.
- 3,86 μm: l'interferenza con CO2 e vapore acqueo nelle fiamme e nei gas di scarico della combustione è efficacemente soppressa.
L'intervallo di temperatura gioca un ruolo importante nella scelta della lunghezza d'onda più adatta per la misurazione. L'equazione di Planck mostra, come illustrato nella Figura 2 per un corpo nero, che il massimo della curva di radiazione si sposta verso l'intervallo delle onde corte all'aumentare della temperatura. Anche nelle applicazioni in cui non è richiesta una scelta selettiva dell'intervallo spettrale, può essere vantaggioso limitare l'intervallo spettrale a una sezione il più possibile ristretta di onde corte. Un vantaggio è che il fattore di emissione effettivo di molti oggetti è più alto per i metalli con lunghezze d'onda più corte. Inoltre, questa limitazione ha un effetto positivo sull'accuratezza, in quanto i sensori con un intervallo spettrale ristretto sono meno influenzati dalle variazioni del fattore di emissione dell'oggetto misurato, come si può notare nella Figura 7.

Fig. 7 Dipendenza dell'emissività errata da diverse lunghezze d'onda
Design costruttivo
I termometri a infrarossi sono prodotti in una varietà di configurazioni che differiscono in termini di ottica, elettronica, tecnologia, dimensioni e alloggiamento. Ciò che è comune, tuttavia, è la catena di elaborazione del segnale, che inizia con un segnale IR e termina con un segnale di uscita elettronico. Questa catena di misura generale inizia con un sistema ottico composto da lenti e/o fibre ottiche, filtri e rilevatore.
Da un punto di vista applicativo, il campo visivo è la caratteristica essenziale dell'ottica, ovvero quanto è grande il punto di misura a una determinata distanza. Il rapporto tra la distanza di misura e il diametro del punto di misura è descritto dal rapporto di distanza. In pratica, si può scegliere tra pirometri con ottica fissa e focalizzabile. I dispositivi con ottica fissa mettono a fuoco solo l'oggetto nel punto focale. Alle altre distanze di misura, il diametro del punto di misura aumenta in modo sproporzionato rispetto al rapporto di distanza calcolato. Queste ottiche sono adatte soprattutto per oggetti di grandi dimensioni. L'uso di ottiche focalizzabili è consigliato per oggetti piccoli o per distanze di misura maggiori. Grazie alla possibilità di regolare la distanza di misura, i pirometri con ottiche focalizzabili possono essere utilizzati in modo molto più flessibile.
Quando si specifica e si confronta il diametro del punto di misura, è importante sapere a quale percentuale della potenza radiante si riferisce la specifica. Ad esempio, un punto di misura basato sul 98% dell'energia è due volte più grande di un diametro basato sul 90% della potenza. Questo può portare a notevoli errori di misura, soprattutto con bersagli piccoli delle stesse dimensioni del punto di misura del pirometro.
Un altro aspetto dell'ottica è il puntamento del bersaglio. Nei dispositivi privi di un dispositivo di puntamento, l'obiettivo è fissato alla superficie e misura la temperatura superficiale. Questo vale soprattutto per i sensori fissi che sono allineati a oggetti sufficientemente grandi e in cui non è richiesta una misurazione precisa. Per gli oggetti più piccoli o per gli strumenti che misurano a distanze maggiori, è indispensabile un dispositivo di avvistamento sotto forma di ottica passante, di spot luminoso o di raggio laser.
La sensibilità del pirometro è determinata dall'uso di diversi rivelatori e filtri. Come si può vedere dalla Figura 8, i rilevatori di solfuro di piombo offrono la sensibilità più elevata e le termopile quella più bassa. La maggior parte dei rivelatori funziona secondo il principio fotoelettrico (la radiazione IR incidente provoca un segnale di tensione) o si basa sulla fotoconduttività (la radiazione IR incidente modifica la resistenza).
A causa della bassa energia della radiazione, alle basse temperature sono necessari intervalli spettrali a banda larga e quindi lunghezze d'onda di misurazione più lunghe. A temperature più elevate, la sensibilità viene notevolmente ridotta da filtri a banda stretta. Questo riduce al minimo le interferenze dipendenti dalla lunghezza d'onda.
Da un punto di vista applicativo, il campo visivo è la caratteristica essenziale dell'ottica, ovvero quanto è grande il punto di misura a una determinata distanza. Il rapporto tra la distanza di misura e il diametro del punto di misura è descritto dal rapporto di distanza. In pratica, si può scegliere tra pirometri con ottica fissa e focalizzabile. I dispositivi con ottica fissa mettono a fuoco solo l'oggetto nel punto focale. Alle altre distanze di misura, il diametro del punto di misura aumenta in modo sproporzionato rispetto al rapporto di distanza calcolato. Queste ottiche sono adatte soprattutto per oggetti di grandi dimensioni. L'uso di ottiche focalizzabili è consigliato per oggetti piccoli o per distanze di misura maggiori. Grazie alla possibilità di regolare la distanza di misura, i pirometri con ottiche focalizzabili possono essere utilizzati in modo molto più flessibile.
Quando si specifica e si confronta il diametro del punto di misura, è importante sapere a quale percentuale della potenza radiante si riferisce la specifica. Ad esempio, un punto di misura basato sul 98% dell'energia è due volte più grande di un diametro basato sul 90% della potenza. Questo può portare a notevoli errori di misura, soprattutto con bersagli piccoli delle stesse dimensioni del punto di misura del pirometro.
Un altro aspetto dell'ottica è il puntamento del bersaglio. Nei dispositivi privi di un dispositivo di puntamento, l'obiettivo è fissato alla superficie e misura la temperatura superficiale. Questo vale soprattutto per i sensori fissi che sono allineati a oggetti sufficientemente grandi e in cui non è richiesta una misurazione precisa. Per gli oggetti più piccoli o per gli strumenti che misurano a distanze maggiori, è indispensabile un dispositivo di avvistamento sotto forma di ottica passante, di spot luminoso o di raggio laser.
La sensibilità del pirometro è determinata dall'uso di diversi rivelatori e filtri. Come si può vedere dalla Figura 8, i rilevatori di solfuro di piombo offrono la sensibilità più elevata e le termopile quella più bassa. La maggior parte dei rivelatori funziona secondo il principio fotoelettrico (la radiazione IR incidente provoca un segnale di tensione) o si basa sulla fotoconduttività (la radiazione IR incidente modifica la resistenza).
A causa della bassa energia della radiazione, alle basse temperature sono necessari intervalli spettrali a banda larga e quindi lunghezze d'onda di misurazione più lunghe. A temperature più elevate, la sensibilità viene notevolmente ridotta da filtri a banda stretta. Questo riduce al minimo le interferenze dipendenti dalla lunghezza d'onda.
Per ottimizzare il comportamento di risposta dei sistemi di sensori IR, è necessario tenere conto della curva spettrale del rilevatore e delle sue caratteristiche.
L'elettronica del termometro IR linearizza il segnale di uscita del rilevatore per generare un segnale lineare di corrente 0 (4) - 20 mA o di tensione 0(2)-10 V. Questo consente di ottenere una maggiore precisione con intervalli di misura più ampi rispetto alla linearizzazione analogica. La linearizzazione è oggi spesso effettuata via software tramite un microprocessore.
Ciò consente di ottenere una maggiore precisione con intervalli di misurazione più ampi rispetto alla linearizzazione analogica.
Il segnale può anche essere digitalizzato e inviato a un'interfaccia o alimentato a un controllore, indicatore o registratore. A seconda della configurazione, i termometri a infrarossi sono dotati di funzioni aggiuntive come allarmi, memoria min/max regolabile per misure intermittenti, intervalli di misura e tempi di risposta regolabili e funzioni di sample-and-hold.
Come accennato all'inizio, il vantaggio della misurazione della temperatura senza contatto è il breve tempo di risposta. I rivelatori termoelettrici per i dispositivi a bassa temperatura raggiungono tempi di risposta di 30 ms. I rilevatori fotoelettrici per alte temperature hanno tempi di risposta di 2 ms.
Se in un'applicazione si utilizza un sensore con tempi di risposta rapidi, anche gli altri componenti dell'anello di controllo devono consentire velocità di elaborazione o di attuazione corrispondenti.
L'elettronica del termometro IR linearizza il segnale di uscita del rilevatore per generare un segnale lineare di corrente 0 (4) - 20 mA o di tensione 0(2)-10 V. Questo consente di ottenere una maggiore precisione con intervalli di misura più ampi rispetto alla linearizzazione analogica. La linearizzazione è oggi spesso effettuata via software tramite un microprocessore.
Ciò consente di ottenere una maggiore precisione con intervalli di misurazione più ampi rispetto alla linearizzazione analogica.
Il segnale può anche essere digitalizzato e inviato a un'interfaccia o alimentato a un controllore, indicatore o registratore. A seconda della configurazione, i termometri a infrarossi sono dotati di funzioni aggiuntive come allarmi, memoria min/max regolabile per misure intermittenti, intervalli di misura e tempi di risposta regolabili e funzioni di sample-and-hold.
Come accennato all'inizio, il vantaggio della misurazione della temperatura senza contatto è il breve tempo di risposta. I rivelatori termoelettrici per i dispositivi a bassa temperatura raggiungono tempi di risposta di 30 ms. I rilevatori fotoelettrici per alte temperature hanno tempi di risposta di 2 ms.
Se in un'applicazione si utilizza un sensore con tempi di risposta rapidi, anche gli altri componenti dell'anello di controllo devono consentire velocità di elaborazione o di attuazione corrispondenti.

Abb. 8 Curva spettrale di diversi sensori
Misura monocromatica: misura della temperatura a una sola lunghezza d'onda
La misurazione della temperatura a singola lunghezza d'onda misura l'energia emessa da una superficie a una determinata lunghezza d'onda. Il design di questi strumenti varia da sonde portatili con un semplice display esterno a strumenti portatili sofisticati in cui la temperatura viene visualizzata in una finestra di visualizzazione attraverso la quale viene focalizzato l'oggetto. Sono disponibili anche funzioni di memoria e di stampa. La gamma di sensori stazionari in linea va da semplici piccoli rilevatori con elettronica esterna a gruppi robusti e complessi con controllori PID integrati. Fibre ottiche, ottiche trasparenti, dispositivi di puntamento laser, sistemi di raffreddamento ad acqua e scanner sono opzioni utilizzate per il monitoraggio e il controllo dei processi. Recentemente, i pirometri sono stati offerti anche con una videocamera integrata, in modo che il punto di misura possa essere monitorato visivamente dalla sala di controllo oltre alla misurazione. Esistono notevoli differenze in termini di dimensioni, prestazioni, robustezza, flessibilità ed elaborazione del segnale.
Quando si pianificano e si progettano le applicazioni, la configurazione del sensore, i filtri, il campo di temperatura, l'ottica, il tempo di risposta e il fattore di emissione sono criteri importanti che devono essere considerati in dettaglio.
La scelta del campo spettrale IR e del campo di temperatura deve essere sempre considerata in relazione all'applicazione specifica. Dalle curve spettrali mostrate nella Figura 2, si può notare che le lunghezze d'onda corte sono più adatte per le alte temperature, mentre le basse temperature dovrebbero essere misurate nella gamma di lunghezze d'onda più lunghe. Se si devono misurare oggetti trasparenti come vetro o film plastici, è necessario un filtro selettivo a banda stretta. La pellicola di politene, ad esempio, ha un intervallo di assorbimento CH di 3,43 μm, a cui è impermeabile alla radiazione IR. Analogamente, molti materiali simili al vetro hanno un intervallo di opacità di circa 5 μm. Al contrario, un sensore con un filtro nell'intervallo fino a 2 μm consente la misurazione attraverso una finestra di vetro, ad esempio per camere a vuoto o a pressione. Un'altra opzione per la misurazione in camere con punti di misura limitati o con temperature ambientali elevate è l'uso di cavi in fibra ottica.
La misurazione della temperatura IR con una singola lunghezza d'onda è quindi una tecnologia versatile e semplice, sufficiente per molte applicazioni in cui il controllo della temperatura del prodotto è essenziale per una qualità costante del prodotto.
Quando si pianificano e si progettano le applicazioni, la configurazione del sensore, i filtri, il campo di temperatura, l'ottica, il tempo di risposta e il fattore di emissione sono criteri importanti che devono essere considerati in dettaglio.
La scelta del campo spettrale IR e del campo di temperatura deve essere sempre considerata in relazione all'applicazione specifica. Dalle curve spettrali mostrate nella Figura 2, si può notare che le lunghezze d'onda corte sono più adatte per le alte temperature, mentre le basse temperature dovrebbero essere misurate nella gamma di lunghezze d'onda più lunghe. Se si devono misurare oggetti trasparenti come vetro o film plastici, è necessario un filtro selettivo a banda stretta. La pellicola di politene, ad esempio, ha un intervallo di assorbimento CH di 3,43 μm, a cui è impermeabile alla radiazione IR. Analogamente, molti materiali simili al vetro hanno un intervallo di opacità di circa 5 μm. Al contrario, un sensore con un filtro nell'intervallo fino a 2 μm consente la misurazione attraverso una finestra di vetro, ad esempio per camere a vuoto o a pressione. Un'altra opzione per la misurazione in camere con punti di misura limitati o con temperature ambientali elevate è l'uso di cavi in fibra ottica.
La misurazione della temperatura IR con una singola lunghezza d'onda è quindi una tecnologia versatile e semplice, sufficiente per molte applicazioni in cui il controllo della temperatura del prodotto è essenziale per una qualità costante del prodotto.
Misura del rapporto: misura della temperatura a due o più lunghezze d'onda
Dato che il fattore di emissione gioca un ruolo fondamentale nella misurazione accurata della temperatura con i termometri a infrarossi o che ci sono mezzi intermedi nel percorso del fascio, non sorprende che i ricercatori stiano cercando di sviluppare sensori in grado di misurare la temperatura indipendentemente da queste interferenze. Un approccio comune e collaudato è la misurazione del rapporto o multi-colore. Questo metodo misura il rapporto tra l'energia a due diverse lunghezze d'onda, anziché la quantità assoluta di energia a una sola lunghezza d'onda. Il termine "misurazione multicolore" deriva dalla vecchia idea di combinare i colori visibili con la temperatura. Questa idea - e quindi anche il termine - è ormai un po' superata, ma è ancora comunemente utilizzata.
L'efficacia di questo concetto si basa sul fatto che le variazioni delle proprietà superficiali dell'oggetto di misura o degli ostacoli situati nel cono visivo dell'oggetto di misura vengono percepite allo stesso modo da entrambi i rilevatori. Pertanto, il rapporto tra i segnali di uscita dei sensori rimane invariato, così come la temperatura misurata. La Figura 9 mostra una rappresentazione semplificata di un pirometro che funziona secondo questo principio.
L'efficacia di questo concetto si basa sul fatto che le variazioni delle proprietà superficiali dell'oggetto di misura o degli ostacoli situati nel cono visivo dell'oggetto di misura vengono percepite allo stesso modo da entrambi i rilevatori. Pertanto, il rapporto tra i segnali di uscita dei sensori rimane invariato, così come la temperatura misurata. La Figura 9 mostra una rappresentazione semplificata di un pirometro che funziona secondo questo principio.

Fig. 9 Misurazione del rapporto
Misurando il rapporto invece del valore assoluto, si possono evitare le imprecisioni causate da un fattore di emissione sconosciuto o variabile nelle condizioni descritte sopra. La temperatura viene misurata correttamente anche se una parte del campo visivo è oscurata da materiali più freddi, come polvere, vapore, infissi o finestre.
Finché il mezzo interposto tra l'oggetto e il sensore non attenua selettivamente alcune lunghezze d'onda, il rapporto rimane costante e quindi anche la temperatura misurata dal termometro rimane costante.
Questo metodo è quindi adatto ad applicazioni che sarebbero difficili o impossibili da risolvere con altre tecniche di misurazione, ad esempio la misurazione della temperatura nei forni per cemento o la misurazione attraverso una finestra che si appanna durante il processo, come nel caso della fusione sotto vuoto dei metalli. Tuttavia, va notato che questi cambiamenti dinamici devono essere percepiti allo stesso modo da entrambi i sensori, cioè i cambiamenti devono interessare tutte le lunghezze d'onda allo stesso modo.
Naturalmente, questo metodo presenta anche dei limiti che devono essere presi in considerazione. La misurazione del rapporto non è adatta a emettitori colorati come l'alluminio. Allo stesso modo, non può essere utilizzata per misurare attraverso finestre con trasmissione variabile o Pyrex caldo. Inoltre, questo metodo tende a registrare e misurare le temperature di fondo se queste sono superiori alla temperatura dell'oggetto da misurare.
Finché il mezzo interposto tra l'oggetto e il sensore non attenua selettivamente alcune lunghezze d'onda, il rapporto rimane costante e quindi anche la temperatura misurata dal termometro rimane costante.
Questo metodo è quindi adatto ad applicazioni che sarebbero difficili o impossibili da risolvere con altre tecniche di misurazione, ad esempio la misurazione della temperatura nei forni per cemento o la misurazione attraverso una finestra che si appanna durante il processo, come nel caso della fusione sotto vuoto dei metalli. Tuttavia, va notato che questi cambiamenti dinamici devono essere percepiti allo stesso modo da entrambi i sensori, cioè i cambiamenti devono interessare tutte le lunghezze d'onda allo stesso modo.
Naturalmente, questo metodo presenta anche dei limiti che devono essere presi in considerazione. La misurazione del rapporto non è adatta a emettitori colorati come l'alluminio. Allo stesso modo, non può essere utilizzata per misurare attraverso finestre con trasmissione variabile o Pyrex caldo. Inoltre, questo metodo tende a registrare e misurare le temperature di fondo se queste sono superiori alla temperatura dell'oggetto da misurare.
La Figura 10 mostra un esempio di vari prodotti il cui fattore di emissione varia con la temperatura. La grafite, ad esempio, viene spesso ritenuta spontaneamente un fattore di emissione elevato e costante. È vero il contrario: il fattore di emissione aumenta da 0,4 a 0,65 in un intervallo compreso tra 20°C e 1100°C.
Per gli emettitori colorati il cui fattore di emissione varia con la lunghezza d'onda, esistono termometri multicolore che misurano l'energia di un'intera gamma di lunghezze d'onda. Tali applicazioni sono precedute da un'analisi dettagliata delle proprietà superficiali del prodotto in questione. È necessario analizzare la relazione tra fattore di emissione, temperatura, lunghezza d'onda e chimica della superficie. Questi dati possono essere utilizzati per impostare algoritmi che mettano in relazione l'emissione a diverse lunghezze d'onda con la temperatura in modo significativo.
Se nel campo visivo è presente un mezzo le cui dimensioni delle particelle corrispondono a una delle lunghezze d'onda utilizzate per la misurazione, anche il rapporto viene distorto.
Nonostante queste limitazioni, la misurazione del rapporto funziona molto bene in numerose applicazioni. In alcune applicazioni, questo metodo è la soluzione migliore, se non l'unica, per misurare la temperatura.
Per gli emettitori colorati il cui fattore di emissione varia con la lunghezza d'onda, esistono termometri multicolore che misurano l'energia di un'intera gamma di lunghezze d'onda. Tali applicazioni sono precedute da un'analisi dettagliata delle proprietà superficiali del prodotto in questione. È necessario analizzare la relazione tra fattore di emissione, temperatura, lunghezza d'onda e chimica della superficie. Questi dati possono essere utilizzati per impostare algoritmi che mettano in relazione l'emissione a diverse lunghezze d'onda con la temperatura in modo significativo.
Se nel campo visivo è presente un mezzo le cui dimensioni delle particelle corrispondono a una delle lunghezze d'onda utilizzate per la misurazione, anche il rapporto viene distorto.
Nonostante queste limitazioni, la misurazione del rapporto funziona molto bene in numerose applicazioni. In alcune applicazioni, questo metodo è la soluzione migliore, se non l'unica, per misurare la temperatura.

Fig. 10 In molti materiali il fattore di emissione varia con la temperatura. Questa figura mostra alcuni materiali comuni.
Sintesi
La Figura 11 mostra ancora una volta gli elementi essenziali di un'applicazione. L'aspetto più importante è la superficie dell'oggetto da misurare. Nella scelta dello strumento più adatto, occorre tenere conto delle dimensioni dell'oggetto da misurare, dell'intervallo di temperatura, del fattore di emissione, della sensibilità spettrale e del tempo di risposta.
Inoltre, nella scelta dello strumento più adatto occorre tenere conto anche delle condizioni ambientali, ad esempio la presenza di fiamme, di riscaldatori radianti IR, di forni a induzione e della natura dell'atmosfera (polvere, finestre contaminate, fumo, calore, ecc.).
Inoltre, nella scelta dello strumento più adatto occorre tenere conto anche delle condizioni ambientali, ad esempio la presenza di fiamme, di riscaldatori radianti IR, di forni a induzione e della natura dell'atmosfera (polvere, finestre contaminate, fumo, calore, ecc.).

Fig. 11 Fattori di disturbo
La misurazione della temperatura a infrarossi è una tecnologia matura che viene continuamente ottimizzata e adattata a nuove applicazioni. Dimostra il suo valore ogni giorno in un'ampia gamma di settori industriali e nella ricerca. Se la tecnologia di base viene compresa correttamente e si tiene conto di tutti i parametri applicativi rilevanti, questo metodo di misura produce generalmente i risultati desiderati, a condizione che lo strumento sia stato installato con cura. In questo contesto, per "accurata" si intende che il sensore viene fatto funzionare entro le sue specifiche e che sono state prese sufficienti precauzioni per mantenere l'ottica libera da contaminazioni e depositi.
Un criterio per la scelta di un produttore di termometri dovrebbe quindi essere la disponibilità di accessori di protezione e installazione. Si deve anche tenere conto della misura in cui questi accessori consentono di rimuovere rapidamente il sensore e di sostituirlo, se necessario. Se si rispettano queste linee guida, i moderni termometri a infrarossi funzionano spesso in modo più affidabile dei sensori a termocoppia o Pt100.
Un criterio per la scelta di un produttore di termometri dovrebbe quindi essere la disponibilità di accessori di protezione e installazione. Si deve anche tenere conto della misura in cui questi accessori consentono di rimuovere rapidamente il sensore e di sostituirlo, se necessario. Se si rispettano queste linee guida, i moderni termometri a infrarossi funzionano spesso in modo più affidabile dei sensori a termocoppia o Pt100.